Quell’italiano incerto ai tempi del web
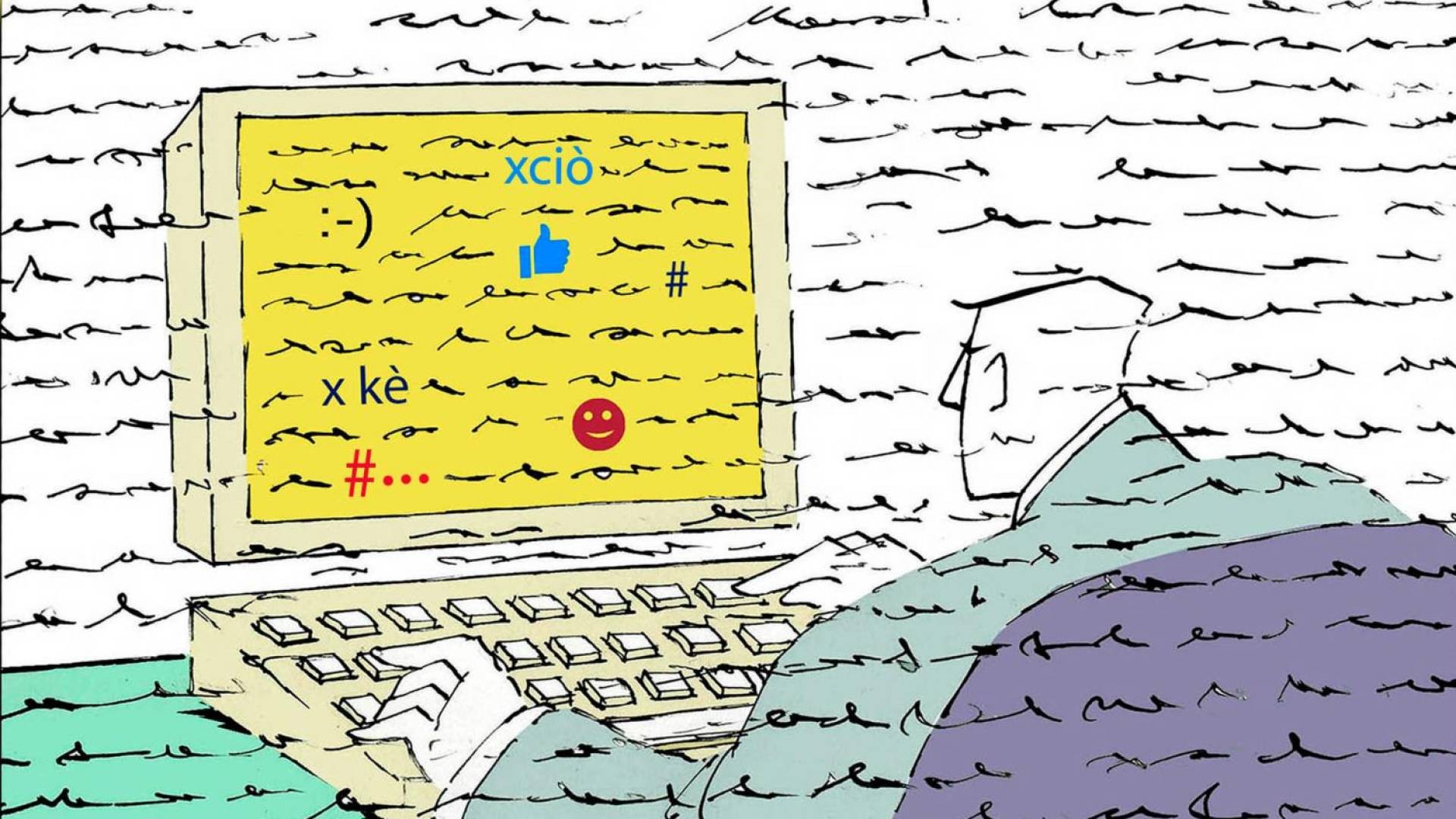
La telematica, negli ultimi decenni, sta rivoluzionando radicalmente il nostro modo di vivere e di comunicare; e, al pari di tutte le epocali rivoluzioni, è stata oggetto di disparate indagini. A tal riguardo, il professor Sergio Lubello, ordinario di Linguistica italiana e di Storia della lingua italiana all’Università di Salerno, ha curato il volume «L’e-taliano. Scriventi e scritture nell’era digitale» (Cesati editore), una miscellanea comprendente cinque contributi, che affrontano la problematica sotto varie angolazioni. Vi si esaminano le caratteristiche della nuova lingua del web, frammentaria, dialogica e spesso banalizzata; le modalità di impiego delle tecnologie informatiche nella didattica dell’italiano; le scritture spontanee nate sulla rete, connesse a fenomeni riemergenti, e un po’ inquietanti, di semi-analfabetismo.
Professor Lubello, secondo lei, internet ci ha reso più liberi e democratici, oppure è stato soltanto un mito illusorio?
«La questione è complessa e viene dibattuta già da tempo con opinioni contrastanti; mi limito a dire che l’accesso libero alle informazioni è sacrosanto, quindi valuto positivamente la possibilità offerta dalla rete di usufruire anche virtualmente di risorse di difficile accesso o anche solo semplicemente ubicate in sedi lontane da noi. Pensiamo solo alla digitalizzazione di manoscritti antichi e di patrimoni librari realizzata da molte biblioteche e archivi nel mondo: il fatto che standosene a casa al proprio tavolo di lavoro si possa consultare comodamente un manoscritto, quasi sempre in ottima riproduzione digitale, non mi pare cosa da poco, non solo in termini di risparmio di tempo e denaro. Altro discorso merita il rapporto con una mole indiscriminata di notizie e di dati, così come la libertà con cui chiunque può scrivere ciò che vuole sul web. Rinvio a un bel saggio di qualche anno fa ricco di spunti, Presi dalla rete di Raffaele Simone, che già nel titolo evoca rischi e pericoli, soprattutto per i nativi digitali».
Lei ritiene che le risorse digitali costituiscano un valido ausilio per l’insegnamento della lingua italiana a scuola e all’università?
«Se ben usate, certamente sì. Ma ciò chiama in causa un aspetto cruciale, la formazione degli insegnanti: al momento in Italia non sono previsti corsi (obbligatori) che consentano a un futuro insegnante di inquadrare e affrontare gli aspetti didattici legati alle modalità nuove di lettura e di scrittura; da una parte l’insegnante di buona volontà cerca da sé strategie per misurarsi con un mondo che spesso conosce appena; dall’altra insegnanti meno giovani tendono a stigmatizzare quel mondo, ignorandolo invece di attrezzarsi per affrontarlo. Un insegnante dovrebbe, per esempio, aiutare gli studenti a districarsi tra fonti eterogenee, ciò che per i nativi digitali non è un problema secondario perché spesso vengono sopraffatti da un numero esorbitante di informazioni; navigazione insomma con rischio di naufragio. Dai dati che provengono da molte indagini internazionali sulla literacy mi stupisco sempre della posizione costantemente in alto della Finlandia, e mi chiedo ogni volta come si studi da quelle parti. Ebbene in Finlandia si comincia a sei anni a usare l’ipad e lo smartphone in classe per varie attività tra cui quella di scoprire le cosiddette fake news, cioè di fatto i primi rudimenti di filologia digitale».
L’e-taliano (per usare la categoria coniata dal linguista Giuseppe Antonelli) è da considerarsi una nuova frontiera del nostro idioma o, piuttosto, il segno dell’imbarbarimento dei tempi odierni?
«Direi né l’uno né l’altro; la lingua cambia di continuo: non esiste una norma per sempre e neppure un solo modo di scrivere e di parlare. La scrittura è stata quasi desacralizzata dalle nuove tecnologie digitali, nel senso che ormai è pratica quotidiana di molti, di tutti e le occasioni si sono moltiplicate; certamente si tratta di un modo di scrivere sui generis, “un parlar spedito”. Ben venga quindi la scrittura come attività giornaliera, dai social network alle conversazioni in chat, purché quel tipo di scritto non diventi un registro unico – codice factotum l’ho definito qualche tempo fa – cioè l’unica possibilità di esprimersi per iscritto: a scuola e all’università lo scritto è ben diverso, richiede cura, attenzione, capacità argomentativa; anche la scrittura deve insomma rispecchiare la diversità e la molteplicità dei diversi usi e contesti comunicativi».
In particolare, gli sms, i tweet, le chat hanno introdotto un nuovo slang, fatto di neologismi, icone, abbreviazioni. Si potrebbe avallare la definizione di «scrittura liquida», quale riflesso della «società liquida» teorizzata dal sociologo Zygmunt Bauman?
«Il termine di “scrittura liquida” coniato da Giuliana Fiorentino ricorda certamente il concetto di liquidità molto caro a Bauman; nella fattispecie viene applicato per caratterizzare una scrittura tipica delle produzioni spontanee sul web da parte delle nuove generazioni (ma non solo) e che Fiorentino indaga in varie prospettive da alcuni anni: scrittura che ricorda quella “selvaggia”, caratterizzata da vari fenomeni di substandard e di informalità particolarmente marcata, ma soprattutto da molta incertezza normativa; quindi il concetto di liquidità è ben appropriato a un tipo di scrittura che procede disinvolta, senza argini e senza controllo».
Nel suo contributo, lei parla del «burosauro». Perché il web non riesce a contrastare a dovere gli aspetti più farraginosi del linguaggio burocratico e aziendalistico?
«Perché si è trattato, almeno finora, di una sfida raccolta solo in parte: di fatto molte possibilità non sono sfruttate, e le buone pratiche sono dovute a iniziative isolate che non fanno sistema. La cosiddetta “agenda digitale”, peraltro, non prevede azioni specifiche in tema di scrittura. Tuttavia è bene essere ottimisti: come ho scritto in un altro lavoro, probabilmente la “semplificazione” del burocratese, in passato auspicata e promossa senza successo dal legislatore, si realizzerà naturaliter sul web, col tempo. Staremo a vedere».