Il grande wrestling in Ticino: in palio il titolo europeo e il primo incontro svizzero tra tag team femminili
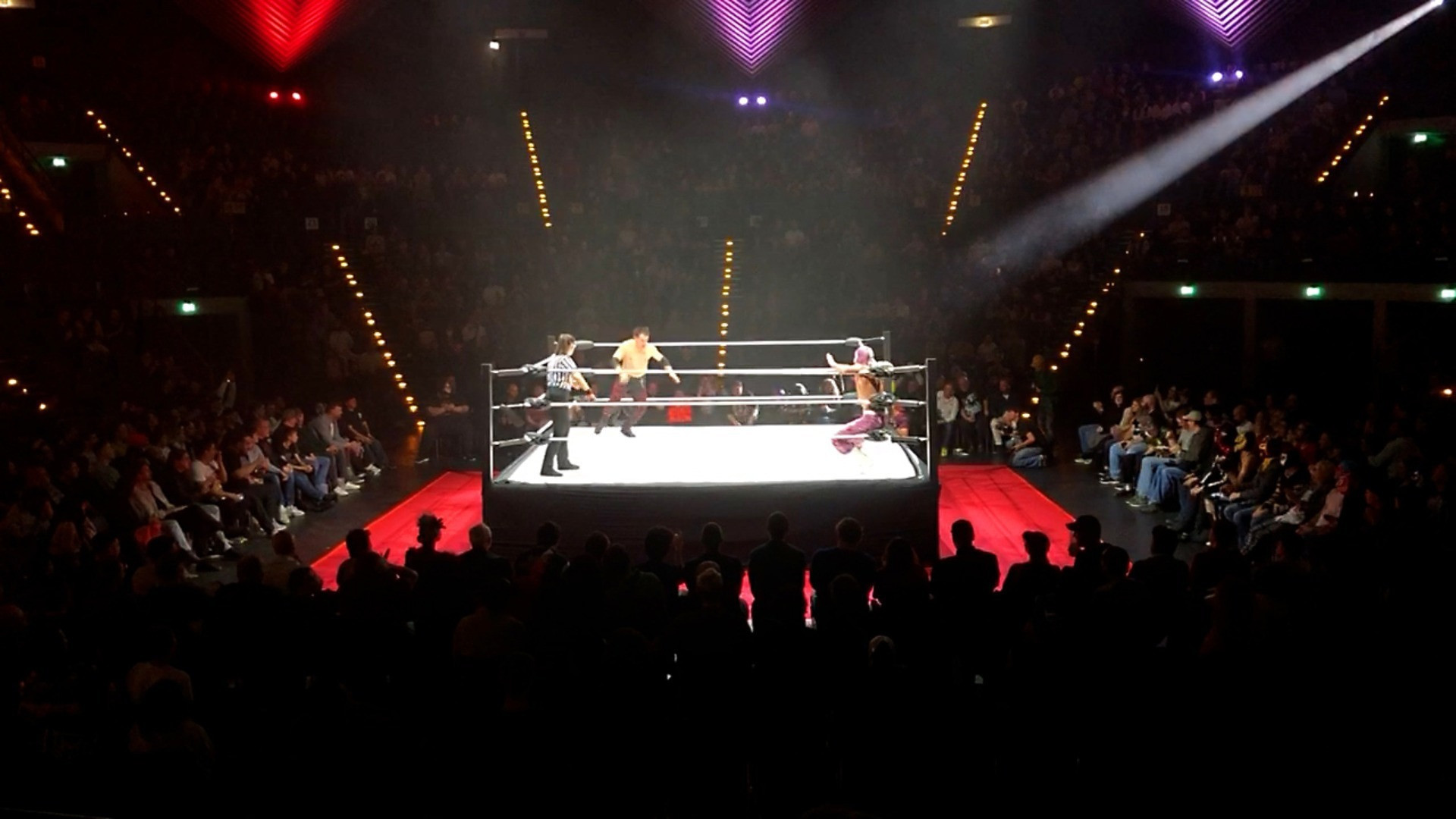
Anni fa, in una palestra della Florida, Luca Rusconi ha fatto una promessa ai suoi maestri, i leggendari Dudley Boyz: «Magari non diventerò mai una star in televisione, ma vi assicuro che non avrete sprecato il vostro tempo: lo restituirò al wrestling». Erano i suoi primi passi su un ring lontano dal Ticino. Da allora sono passati quasi due decenni, migliaia di cadute, chilometri, allenamenti. Oggi quella promessa prende la forma di una piccola filiera: eventi dal vivo, corsi per adulti, corsi per bambini, una scena che ha messo radici anche da noi.
Luca, in arte Belthazar, è un caso raro: cresciuto all’ombra dei miti televisivi, è andato a studiare l’arte del ring dai Dudley Boyz – uno dei tag team più titolati della storia WWE – e poi è tornato a casa, in un luogo dove il wrestling non appartiene alla tradizione, per provare a costruire qualcosa da zero. In mezzo, l’incontro con alcune delle più grandi leggende del wrestling mondiale e, oggi, lo sforzo di tradurre quell’immaginario globale in show sostenibili e in percorsi formativi.

Sabato 22 novembre, con «Wrestling Live Lugano XV», la sua Pro Wrestling Live Events torna in scena con una Royal Rumble e una card piena, ma anche con una novità assoluta per la Svizzera: un incontro a squadre tutto al femminile. Da qui parte il racconto di Rusconi.
Partiamo proprio dalla serata del 22 novembre: Royal Rumble,
titoli in palio e una «prima» femminile per la Svizzera. Che cosa si troverà il
pubblico?
È uno show pensato per tutte le età, dai bambini agli
adulti. Riproporremo la Royal Rumble con quindici atleti: ogni 90 secondi entra
qualcuno di nuovo e alla fine l’ultimo che resta sul ring vince la Lugano Cup.
È una formula che funziona molto bene, soprattutto con i più piccoli, perché
vedono praticamente tutto il roster nello stesso match. La card è molto ricca: ci sarà la difesa del titolo europeo
da parte di Fabio Ferrari contro il torinese Violenzo, e il titolo svizzero in
palio tra Deimos e il «carrarmato» Drake Destroyer. Avremo uno dei nostri talenti di
casa, il b-boy luganese Reckless JD, contro un nome europeo in crescita come lo spagnolo Leo Cristiani, un
tre way match per la 3 Way Cup e poi la grande novità: un tag team match
femminile, due contro due. Per noi è motivo di orgoglio, perché sarà una prima
assoluta in Svizzera, qualcosa che finora non si era mai visto dal vivo nel
nostro Paese. Vogliamo che sia chiaro che il wrestling non è solo una questione
maschile: le atlete portano qualità, intensità e un modo diverso di vivere il
ring. E infine ci sarò anch’io, che ho lanciato una open
challenge: l’ha raccolta Red Jack, un talento emergente dalla Svizzera francese.
Sarà una bella sfida, fino all’ultimo colpo.

I bambini che hanno assistito al primo show del 2012 oggi sono diventati giovani adulti, con famiglie che
vi seguono da più di dieci anni. Com'è cambiato lo sguardo del pubblico
ticinese sul wrestling?
All’inizio il problema era far entrare la gente in sala.
Per molti il wrestling era una «americanata», qualcosa di finto, di poco
interessante. In Ticino non fa parte della cultura sportiva tradizionale,
quindi c’era una soglia di diffidenza da superare. Dal primo show del 2012, però, abbiamo visto una cosa: una
volta che il pubblico viene, poi tende a tornare. Alcune famiglie ci seguono
davvero da più di dieci anni. Ci sono persone che mi dicono: «Ti ho visto da
bambino al primo spettacolo, me lo ricordo ancora». I genitori spesso arrivano
pensando di accompagnare solo i figli e, alla fine, sono quelli che si esaltano
di più. Il pregiudizio iniziale c’è ancora, specie in chi non ci ha
mai visti, ma lo si combatte con la qualità e con la coerenza: show curati,
rispetto degli orari, sicurezza, attenzione ai dettagli. Alla lunga questo
costruisce fiducia.
Il wrestling vive di personaggi e di trame, nell'eterna lotta tra il bene e il male, ma voi avete
solo due grandi eventi all’anno. Come si fa storytelling con questa cadenza,
senza perdere nessuno per strada?
Ogni tanto proviamo a costruire delle storie che
attraversano più show, per dare qualcosa in più a chi ci segue regolarmente. È
successo, per esempio, con una rivalità che mi ha portato con il grande D3 da Lugano a Miami e
poi di nuovo in Ticino. In quel caso il presentatore si è preso qualche minuto
per raccontare il contesto al pubblico. Però, con due eventi all’anno, non può essere la regola.
Dobbiamo sempre partire dal presupposto che una parte importante delle persone
in sala ci vede per la prima volta, o ci vede una volta all’anno e basta.
Quindi la struttura base è chiara: le storie devono iniziare e finire
all’interno della singola serata. Ogni match è una piccola narrazione autonoma: in pochi
minuti bisogna capire chi è il «buono», chi è il «cattivo», quali sono i
caratteri in gioco. Se chiedi al pubblico di doversi «aggiornare» prima di
entrare, lo perdi. Le eccezioni funzionano se restano eccezioni; altrimenti
diventa tutto troppo complicato.
In quei dieci-quindici minuti, quindi, gli atleti devono
fare atletica, recitare e guidare le emozioni. Come li prepari a questa
complessità nei tuoi corsi?
Nei corsi dividiamo sempre due grandi blocchi: la parte
fisica-tecnica e la parte psicologica. La prima, paradossalmente, è quella più
«semplice»: preparazione atletica, esecuzione delle mosse, imparare a cadere, a
proteggersi, a coordinarsi. È lavoro, è fatica, ma è comunque qualcosa di molto
concreto. La parte psicologica, la ring psychology, è la più
difficile. È lì che si decide se un match «funziona» o no. Insegniamo ai
ragazzi a farsi domande: dove ha senso mettere questa mossa? Siamo all’inizio,
posso già usare la finisher o devo costruire il momento? Come faccio a far
capire al pubblico che sono io il «cattivo»? È la stessa logica di un film o di un romanzo: non inizi con
il colpo di scena finale. Prima presenti i personaggi, poi arriva il conflitto,
poi la risoluzione. Nel wrestling è uguale, solo che devi condensare tutto in
otto, dieci minuti. E, mentre lo fai, devi anche pensare alla sicurezza tua e
del tuo avversario.
La tua attività di insegnamento si divide tra Como a Taverne: quest’anno avete strutturato anche un
percorso per bambini. Che tipo di corso è e che risposta avete avuto?
I corsi per adulti li teniamo a Como dove abbiamo
spazio e attrezzature adeguate. In Ticino, a Taverne, da settembre abbiamo
avviato un programma specifico per bambini. Non è un semplice corso mensile, ma
un percorso chiuso di 12-13 allenamenti, con un inizio e una fine. Si parte da basi sportive generali – una decina di esercizi
specifici, da imparare con calma – e poi si inseriscono elementi tecnici di
wrestling adatti all’età, molto controllati. Niente voli spericolati o manovre
rischiose: lavoriamo su movimenti sicuri, sulla coordinazione, sul rispetto
delle consegne. Il «finale di stagione» è una piccola dimostrazione per i
genitori: ogni bambino avrà il suo personaggio, un costume, un’entrata con la
musica. Il match durerà poco, ma vivranno l’esperienza completa di salire sul
ring, sentire il pubblico – che saranno mamma, papà e pochi invitati – e
interpretare un ruolo. Per loro è enorme.

Sul piano educativo, cosa rende il wrestling diverso da
altri sport di contatto?
La cosa che lo distingue di più è la dimensione di
collaborazione. In molti sport di contatto tu cerchi di prevalere sull’altro,
ma puoi difenderti, puoi parare, puoi evitare. Nel wrestling, quando devi
subire una mossa, non ti puoi difendere nel senso classico: devi collaborare
perché l’altro la esegua in sicurezza. Questo significa che ti devi fidare veramente del tuo
compagno di lavoro, perché basta un errore per farsi male. Per gli adulti
questa cosa è ancora più marcata. Per i bambini la portiamo su un piano più
leggero, ma il messaggio è lo stesso: non è «io contro di te», è «io con te». Poi c’è il rispetto delle regole, l’accettare che ci siano
dei ruoli, il gestire le emozioni. È un teatro fisico: recitazione e atletica
insieme. Non a caso, grazie al wrestling, ho potuto lavorare anche come stunt
e, in alcuni casi, come attore in produzioni televisive: chi cerca questo tipo
di figura sa che un wrestler sa cadere, sa prendersi colpi in modo credibile
senza farsi male e, in più, sa stare davanti a una telecamera.
A proposito di maestri: ti sei formato con i
Dudley Boyz. Perché proprio loro e cosa ti hanno insegnato davvero?
La scelta è nata quasi per caso. Durante un tour in Canada
ho incontrato una lottatrice che mi ha detto: «Se vuoi andare negli Stati
Uniti, devi assolutamente andare da loro». Mi sono fidato. Arrivato alla Team 3D Academy, vicino a Orlando, mi sono
reso conto che fino a quel momento avevo solo delle basi tecniche. Pensavo di
avere capito il pro wrestling, in realtà non avevo capito quasi nulla. Bubba
Ray e D-Von Dudley mi hanno aperto un mondo: mi hanno insegnato cos’è davvero
lo storytelling, come costruire un match logico dall’inizio alla fine, come
usare ogni singola mossa per dire qualcosa al pubblico. Parliamo di una coppia che ha vinto titoli ovunque,
riconosciuta come uno dei tag team più decorati della storia. Avere la
possibilità di stare con loro in palestra, ma anche nei backstage di show negli
Stati Uniti, in Inghilterra, in Europa, vale quanto – se non più – di tanti
corsi teorici. A volte, venti minuti di conversazione in macchina con uno di
questi veterani ti danno spunti che ti cambiano il modo di lavorare.

Tra i volti incrociati nei tuoi vent'anni di carriera c’è anche Hulk Hogan...
L’incontro con Hogan è stato particolare. La prima volta, a
Orlando, è arrivato in limousine, già in versione «Hulk Hogan»: bandana, look
iconico, la stessa figura che tutti abbiamo visto in televisione. Non c’era
praticamente distanza tra la persona e il personaggio. Era sempre circondato da
gente: produzione, sceneggiatori, colleghi, tutti avevano qualcosa da dirgli. Alla fine l’ho incrociato in un corridoio tra gli studi e il
backstage. Era da solo. L’ho fermato un attimo, mi sono presentato, gli ho
detto che ero un allievo della Team 3D Academy e che gli dovevo un grazie per
quello che aveva rappresentato. Mi ha risposto con un «God bless you» e ha
proseguito. A Londra è stato ancora più difficile: è rimasto quasi sempre nello
spogliatoio, è uscito solo per il suo segmento e l’ho visto giusto passare. La sua morte è stata un duro colpo, anche se si sapeva che aveva avuto
problemi di salute. Hulk Hogan – Terry Gene Bollea – è stato il volto che ha
reso il wrestling un fenomeno globale, dai primi anni ’80 in poi. Basti pensare
ai WrestleMania storici, alla diffusione della WWF sulle reti televisive
private: ha portato questa disciplina anche in Paesi dove prima non esisteva
quasi. Se si vuole misurare la sua popolarità, il test è semplice:
si può fermare per strada una persona che non ha mai visto un match completo e
spesso saprà dire chi è Hulk Hogan, o almeno riconoscerlo dalla bandana e dalla
maglietta strappata. È stato un’icona pop, oltre che sportiva. Quando è morto si è chiusa una fase precisa
della storia del wrestling. Ma è importante ricordare che un personaggio così
non si costruisce da solo: dietro ci sono sceneggiatori, avversari che si
mettono a disposizione, fotografi, gente che lavora al merchandising, tecnici.
Celebrare Hogan significa celebrare anche tutto quel lavoro di squadra. Oggi
una parte di quella eredità, in termini di carisma globale, è passata a figure
come John Cena.
Dai miti del ring ai palazzetti europei: a inizio novembre
lei è stato protagonista al Tempodrom di Berlino, nel tour d’addio di El Hijo
del Santo. Che segno ha lasciato quella serata?
È stata una tappa molto importante. Ho preso parte a uno
show del tour d’addio di El Hijo del Santo, che per la lucha libre messicana è
una vera leggenda. Il Tempodrom era pieno, circa duemila persone. Molti avevano
la maschera, ma non mi sembravano «ultras» del wrestling: più che altro un
pubblico curioso, pronto a lasciarsi portare. La cosa strana, per me, è stata la calma. Razionalmente, con
un’arena così, un nome di quel peso in cartellone e la responsabilità di non
rovinare niente, avrei dovuto essere molto più teso. Invece ero tranquillo,
concentrato. Quella sera mi ha dato una consapevolezza: magari non sarò
mai una star televisiva, ma quello che faccio lo so fare. E posso portarlo in
giro con dignità, oltre il Ticino.
Guardando avanti, che cosa vedi nel tuo futuro?
Per me l’obiettivo è continuare finché sarò in grado di
fare match di cui andare fiero. Idealmente, ancora una decina d’anni. Uno dei
sogni personali è condividere un giorno il ring con mio figlio, magari in tag
team. Sarebbe un modo simbolico per passare il testimone. Per quanto riguarda la scena, in Ticino ormai c’è un
pubblico fedele. In Svizzera romanda ci sono colleghi che lavorano molto bene,
nella Svizzera tedesca invece c’è ancora tanto spazio, perché il wrestling è
quasi assente. Mi piacerebbe, prima o poi, proporre qualcosa anche lì. Nel frattempo il lavoro è molto concreto: mettere in piedi
eventi curati nei dettagli, formare atleti che sappiano gestire sia la parte
fisica sia quella narrativa, spiegare ai genitori cosa facciamo con i bambini.
Passo dopo passo, una disciplina che non fa parte della nostra cultura inizia a
sembrarne una parte possibile. E questo, per chi aveva promesso di «restituire
qualcosa al wrestling», è già un risultato importante.

