La regola del nemico interno
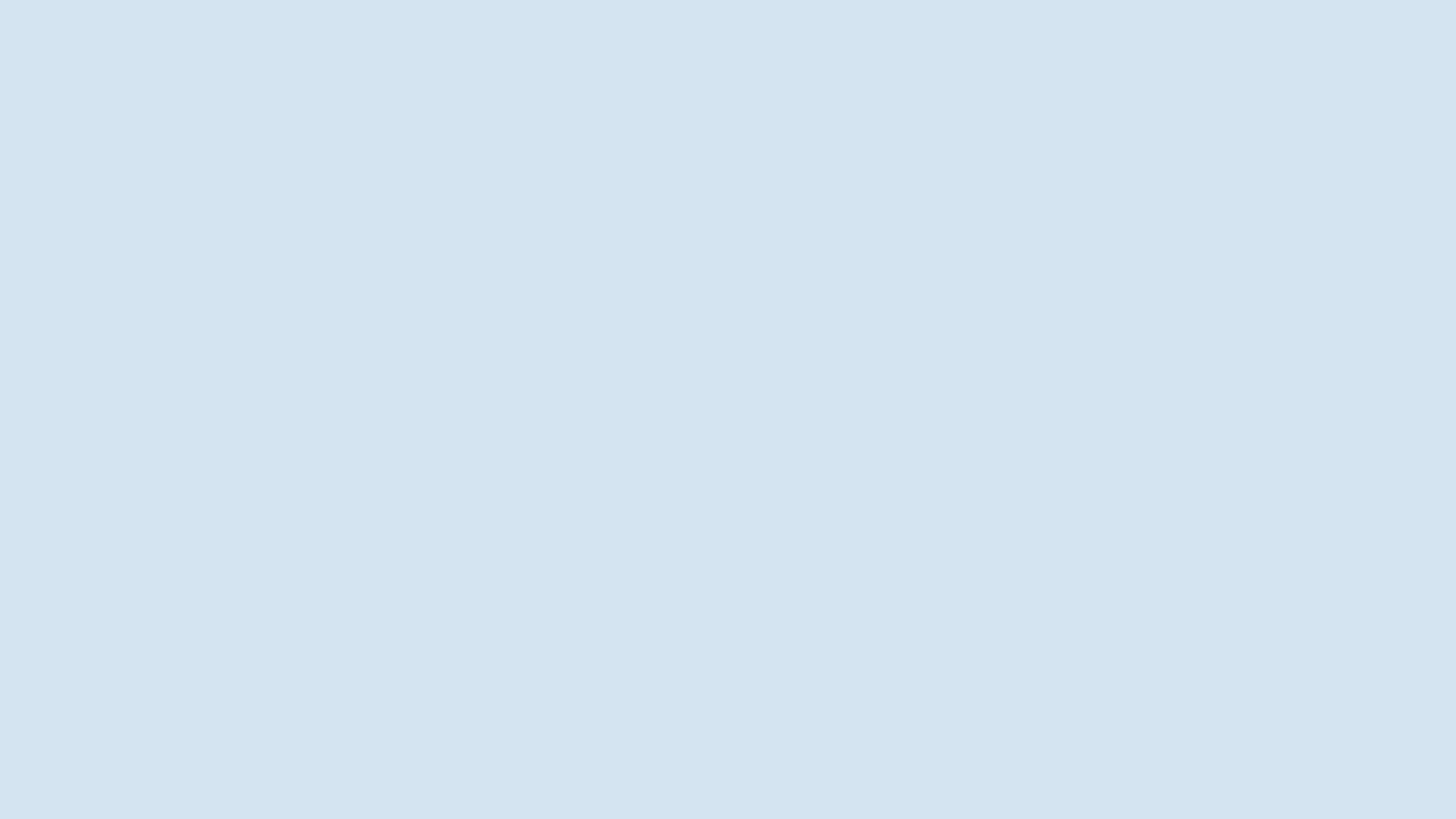
di PIERO OSTELLINO - Una regola che chi governa adotta volentieri, quando è in difficoltà, è inventarsi un nemico. Serve a mobilitare le forze «amiche» e a demonizzare l?avversario politico, in modo da negargli la dignità di avversario e di attribuirgli quella di nemico, cioè di chi gioca con le carte truccate e rappresenta perciò un pericolo. L?Unione Sovietica – in tutta la sua esistenza – aveva supplito alle proprie carenze interne con la proclamata esistenza del «nemico esterno», che nella fattispecie era il capitalismo. Non appena centrodestra e centrosinistra si sono trovati in difficoltà si sono inventati un nemico, questa volta «interno», nelle persone di Gianfranco Fini nel Popolo della Libertà e di Antonio Di Pietro nell?opposizione. Ma si tratta davvero di «nemici» o non piuttosto dei «fantasmi» di un nemico più apparente, e di comodo, che reale? I media italiani – che sulla litigiosità fra e all?interno dei due schieramenti ci fanno i titoli e ci campano – hanno accreditato e continuano a sostenere la presenza di «nemici» autentici sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Ma a guardare bene le cose «dal di dentro», forse, si tratta più di «fantasmi», creati ad arte dalle due leadership e alimentati dai giornali amici, che di fatti concreti. Gianfranco Fini è cofondatore del Popolo della Libertà e, come tale, vorrebbe poter dire la sua nelle decisioni del partito. Ma Berlusconi – l?altro cofondatore e, quel che più conta, l?uomo che per fondare Forza Italia, prima, fonderla con Alleanza Nazionale, poi, ci ha messo la faccia e i soldi – è quello che è. Dicono i suoi stessi amici che non sopporta di ascoltare il suo prossimo più di qualche secondo; poi, prende la parola e non la lascia più. Al suo annichilito interlocutore non resta che «prendere o lasciare». Faceva già così quando era solo un imprenditore e di questo innato egocentrismo – peraltro fondato su una bella intelligenza, una straordinaria capacità di sintesi e su una dedizione al lavoro ammirevole – ha costruito la propria fortuna. Ha continuato a comportarsi allo stesso modo anche in politica, dove, però, le regole del gioco sono diverse. Se negli affari avere la prima e anche l?ultima parola può essere utile, in politica può suscitare reazioni impreviste e non tutte positive. È, probabilmente, questa la ragione principale dell?insofferenza di Fini. Che vorrebbe vivere (almeno) in una «monarchia costituzionale» – temperata cioè da un maggiore pluralismo decisionale – mentre ha la sensazione di essere in una «monarchia assoluta», dove la sola cosa che conta sono la prima e l?ultima parola di un autocrate non vincolato da altre regole che non siano quelle che detta lui stesso a tutti gli altri. L?ex segretario di AN – che all?interno del suo partito si comportava, peraltro, allo stesso modo di Berlusconi nel PdL – ha tradotto questa sua insofferenza psicologica in tutta una serie di dichiarazioni politiche che non sempre coincidono con le posizioni del Popolo della Libertà che sono, poi, le parole d?ordine dettate dal Cavaliere. Ed è a questo punto che nel PdL si è verificato un cortocircuito fra ciò che realmente dice Fini, ciò che ne scrivono i giornali e l?interpretazione che si dà all?interno del partito. Ciò che dice Fini non è una «certa idea della destra» diversa da quella di Berlusconi e ad essa antagonistica. Fini, sulle cose che più interessano a Berlusconi – le leggi di riforma del sistema giudiziario che lo mettano al riparo dai suoi processi – è perfettamente nella linea del partito. Le sue sono, per lo più «parole in libertà» pronunciate in circostanze specifiche più come presidente della Camera che co-ondatore e membro autorevole del PdL. Che la terza carica dello Stato – il cui compito «istituzionale» è di disciplinare i lavori di un ramo del Parlamento – dica, ad esempio, che le riforme costituzionali le si dovrebbero fare possibilmente con una maggioranza più larga possibile (che comprenda quindi anche almeno una parte dell?opposizione) o che le leggi devono essere «uguali per tutti» è del tutto fisiologico, al limite della banalità. Né dovrebbe far scandalo che abbia opinioni diverse dalla Lega sull?immigrazione o, rispetto ai cattolici del PdL, sulla bioetica; siamo, o dovremmo ancora essere, nella fisiologica dialettica di ogni partito che voglia dirsi democratico. Ma le «dissonanze» di Fini sono cadute in un momento di (relativa) debolezza di Berlusconi, inseguito da avvisi di garanzia e dalle testimonianze di un mafioso pentito che racconta di aver sentito un altro mafioso parlare «come se fosse lui il padrone di Fininvest». Cose che in un Paese non afflitto da una sorta di «guerra civile» permanente lascerebbero il tempo che trovano tanto sono strampalate e, quel che più conta, prive di ogni fondamento. Così, coadiuvato dai media – che ci inzuppano il pane – l?establishment del Popolo della Libertà si è inventato in Fini il «nemico interno» di Berlusconi; il «deviazionista» dalla linea del partito, eccetera, eccetera. Una reazione, come ho detto, ampiamente prevedibile, ma un errore sesquipedale sotto il profilo politico. Ne è sortita una sorta di difesa della «sacralità» del Capo che lo danneggia più che favorirlo. In politica, le differenze si gestiscono e si metabolizzano culturalmente, prima ancora che politicamente, e di opinioni, per quanto irrituali, non si fa un «caso», che finisce inevitabilmente col rompere artificialmente l?unità di un gruppo e rivelare – per dirla con linguaggio leninista – «frazionismi» che, alla prova dei fatti, poi, non ci sono o non sono, comunque, componibili in quanto attengono più alla sfera delle personalità in gioco che a quella della Politica. Speculare a ciò che succede nel Popolo della Libertà è quello che accade nell?opposizione, dove le (supposte) divergenze fra Pier Luigi Bersani e Antonio Di Pietro sono più di forma che di sostanza. Bersani – che è stato comunista, cioè membro di un partito dotato di una forte, ancorché discutibile, cultura politica, mentre Di Pietro non ne ha alcuna – vorrebbe fare una opposizione culturalmente e politicamente motivata al Governo di centrodestra laddove Di Pietro si accontenta di cavalcare il vecchio giustizialismo dei tempi in cui era pubblico ministero di Mani pulite e fare (solo) cagnara con manifestazioni come il No-B-day, finita, non a caso, nel nulla. E, fin qui, da una parte e dall?altra, siamo ancora nel campo del «nemico» che giustifica comportamenti propagandistici da entrambe le parti, ma non rivela fratture politiche insanabili: Bersani si è rifiutato di partecipare come PD al No-B-day per non finire a rimorchio dell?IdV; Di Pietro lo accusa di non fare opposizione, se no di essere complice di Berlusconi. Ma se si guardano le cose più «dal di dentro» si vede che le distanze fra i due sono minori. PD, partito (aspirante) riformista della sinistra, e Italia dei Valori, partito che sarebbe difficile definire riformista e tanto meno di sinistra, pescano ancora nell?elettorato anti-berlusconiano sull?onda di Tangentopoli, ma il PD non ha alcuna intenzione di rivedere il proprio pensiero su Mani pulite e, in generale, sulla magistratura, il che fa sì che esso sia assai più vicino all?IdV di quanto non voglia far apparire. Il «teatrino della politica» sta facendo danni più alla reputazione internazionale dell?Italia che alla solidità (peraltro politicamente inconsistente) delle due coalizioni in competizione e, forse, dello stesso Governo (che minaccia di durare tutta la legislatura non facendo le riforme di cui il Paese avrebbe urgente bisogno). Alimenta la psicosi della «guerra civile» fra centrodestra e centrosinistra – mentre una «certa idea dell?Italia» antagonistica, e concretamente applicabile, non l?ha nessuno dei due – legittima quella della (probabile) «dissoluzione» del Popolo della Libertà (mentre né Fini né Berlusconi hanno «una certa idea della destra» e tanto meno fra loro antagonistica); perpetua l?«equivoco» di una opposizione che pare avere una doppia identità (quella del PD e quella dell?IdV), laddove non ne ha invece alcuna. Conferma la crisi culturale prima che politica dell?Italia.