Obama tra due lobby ebraiche
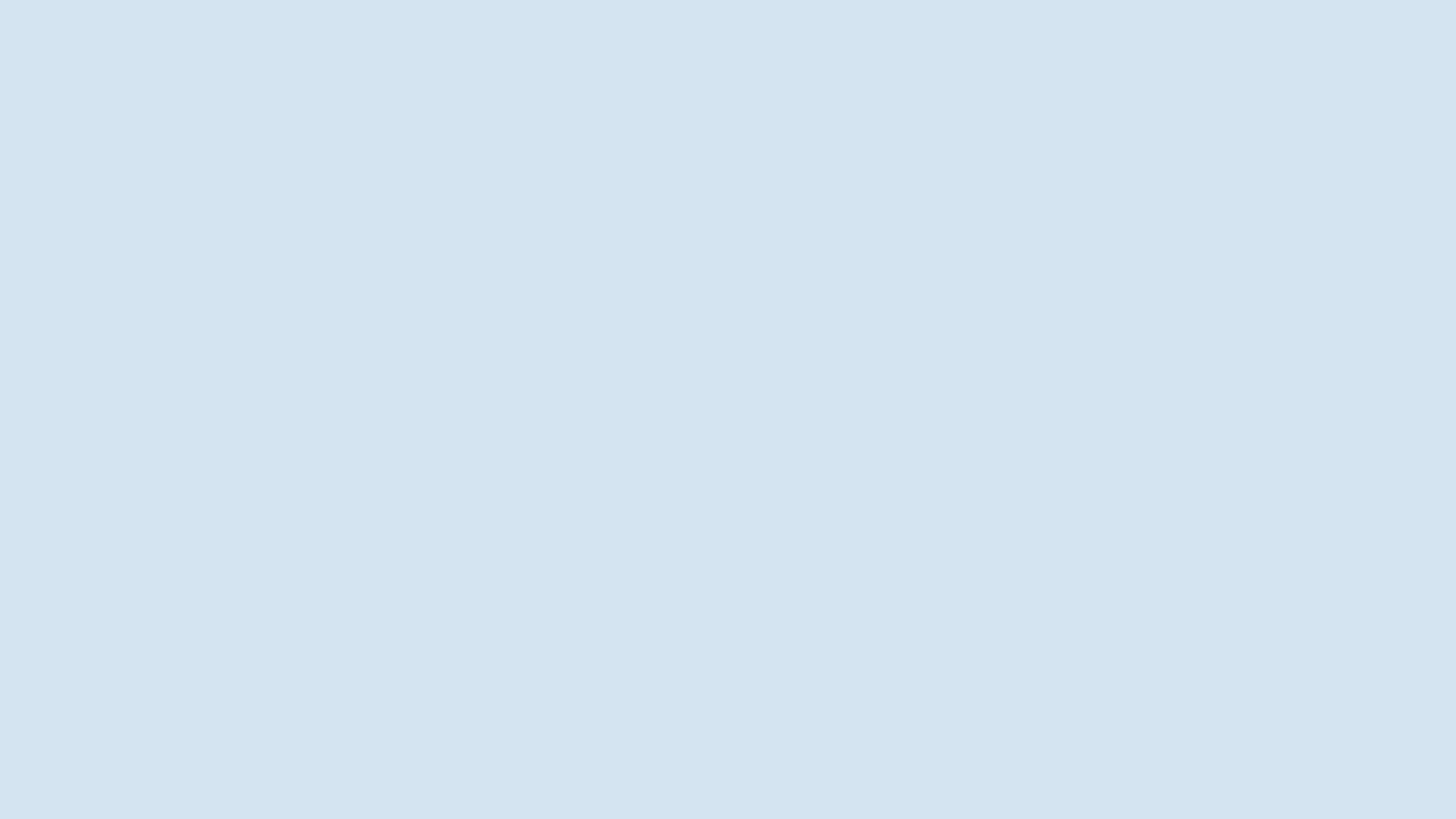
di GERARDO MORINA - Negli Stati Uniti una «lobby» è un gruppo che esercita una pressione in forma ufficiosa, ma in modo aperto e legittimo, su uomini o gruppi politici per influire sulle loro decisioni legislative o amministrative in modo che risultino favorevoli a quelle fasce della cittadinanza delle quali si vogliono tutelare gli interessi. Questa attività politica, che si svolge dietro le quinte del dibattito politico aperto (nelle «lobbies» o corridoi), negli USA è considerata non solo lecita, ma anche necessaria, perché informa i politici delle esigenze reali dell?elettorato e delle varie categorie economiche, sociali, religiose ed etniche alle quali i i cittadini appartengono. Ogni lobby si ritiene dunque altamente rappresentativa, ma non viene vista come dotata di un potere eccezionale, tale da farne, nella lettura che si applica invece a questo termine fuori dagli Stati Uniti, un gruppo dai connotati necessariamente negativi. Né esiste, sempre negli Stati Uniti, una «lobby» per eccellenza. Non a caso quando, tre anni fa, due accademici, Stephen Walt di Harvard e John Mearsheimer dell?università di Chicago, pubblicarono un saggio dal titolo «The Israel Lobby» (la cui tesi era che a Washington esiste un potente gruppo di persone di destra e di sinistra che guida la politica estera americana per conto dello stato ebraico), le comunità ebraiche americane insorsero e i due autori vennero ricoperti di vituperi. La lobby ebraica, si difesero, è negli Stati Uniti uguale a ogni altra lobby e chi sostiene il contrario fa solamente il gioco dei gruppi antisemiti. La storia dei rapporti tra gruppi di pressione ebraico-americani e l?amministrazione di Washington ha sempre ruotato intorno ad un perno fondamentale: fino a che punto il problema della sicurezza dello stato ebraico coincide con gli interessi nazionali degli Stati Uniti? La tendenza, nelle amministrazioni che si sono succedute, fossero esse repubblicane o democratiche, è stata di considerare i termini della questione nettamente coincidenti, al punto che Washington non ha mai nascosto la sua propensione a fornire aiuti economici e militari ad Israele. Ma la Storia evolve perché mutano le circostanze: oggi c?è alla Casa Bianca un presidente come Obama che, pur considerando saldo il legame degli Stati Uniti con Israele, dimostra di voler percorrere, per quanto riguarda la politica mediorientale, una propria via indipendente. Troppo indipendente se i sondaggi dicono che la popolarità del presidente in Israele ha subito, dalla sua elezione, una discesa in picchiata. In più, oggi la comunità ebraica americana, il 4 per cento dell?elettorato statunitense, tendenzialmente democratica (nelle ultime elezioni ha votato in prevalenza per Obama), vede parzialmente sgretolarsi la sua tradizionale compattezza. Ne è prova il debutto negli Stati Uniti di «J street» (J sta per «Jewish»), la nuova lobby ebraica «liberal» fondata 18 mesi fa da Jeremy Ben Ami, un ex collaboratore di Bill Clinton, con un programma politico marcatamente più a sinistra dell?attuale Governo israeliano di Benyamin Netanyahu. La nuova lobby (il suo slogan è «pro-Israele, pro-processo di pace») si distingue perché si propone di bilanciare con un approccio diverso («liberal») le politiche americane in Medio Oriente: avalla l?impegno del presidente Obama per il congelamento completo degli insediamenti israeliani, si dichiara contro ogni tipo di sanzioni all?Iran e ha dato il suo appoggio al controverso rapporto Goldstone sui crimini di guerra commessi a Gaza durante l?operazione Piombo Fuso. «J Street» ha appena tenuto in un albergo di Washington il suo primo congresso annuale, ma senza ricevere una diffusa copertura mediatica e assistendo anzi a defezioni di deputati,democratici e repubblicani, che in un primo tempo avevano assicurato la loro presenza, eccezion fatta per il consigliere per la Sicurezza della Casa Bianca, generale James Jones, che in un discorso ha salutato positivamente la nascita dell?organizzazione. Né «J Street» sembra aver suscitato grandi entusiasmi in Israele, dal momento che nessun esponente del Governo di Tel Aviv ha partecipato all?evento, trascurato anche dall?ambasciatore israeliano a Washington Michael Oren. La nuova lobby, che intende giocare a suo favore la carta del «gap generazionale» data la giovane età media dei suoi membri, vuole contrapporsi al monopolio dell?AIPAC (American-Israeli Public Action Committee), con la quale tuttavia non può rivaleggiare né in potenza né per quanto riguarda la dovizia di fondi presenti nelle sue casse. Dall?establishment ebraico-americano e da Israele «J Street» viene vista pertanto con estrema diffidenza sia per il suo approccio «liberal»contestato dallo stesso partito laburista israeliano, sia per la composizione del «budget» della nuova organizzazione, il cui 10 per cento proverrebbe da contributi arabi o musulmani.Nulla di più deleterio per il presidente Obama, che si trova così tra due fuochi: da una parte l?eterogeneità, per non dire la rivalità, all?interno della comunità ebraica americana, nonché la diffidenza del Governo israeliano e, dall?altra, la posizione del presidente dell?Autorità Nazionale Palestinese (ANP) Abu Mazen. Il quale minaccia le dimissioni essendo deluso da quella che ritiene la «capitolazione» americana davanti al rifiuto di Israele di accettare un totale congelamento dei suoi insediamenti nei Territori.Obama appare sempre più costretto ad una scelta netta, dal momento che le possibilità di una posizione di compromesso sono difficilmente individuabili. Per ora il presidente si è astenuto da ogni commento. Parlerà il 9 novembre a Washington di fronte allo UJC (United Jewish Communities), la federazione delle comunità ebraiche americana. Sarà la prima volta dal suo insediamento che Obama terrà un discorso di fronte ad una «lobby» ebraica.
