Profezie azzeccate
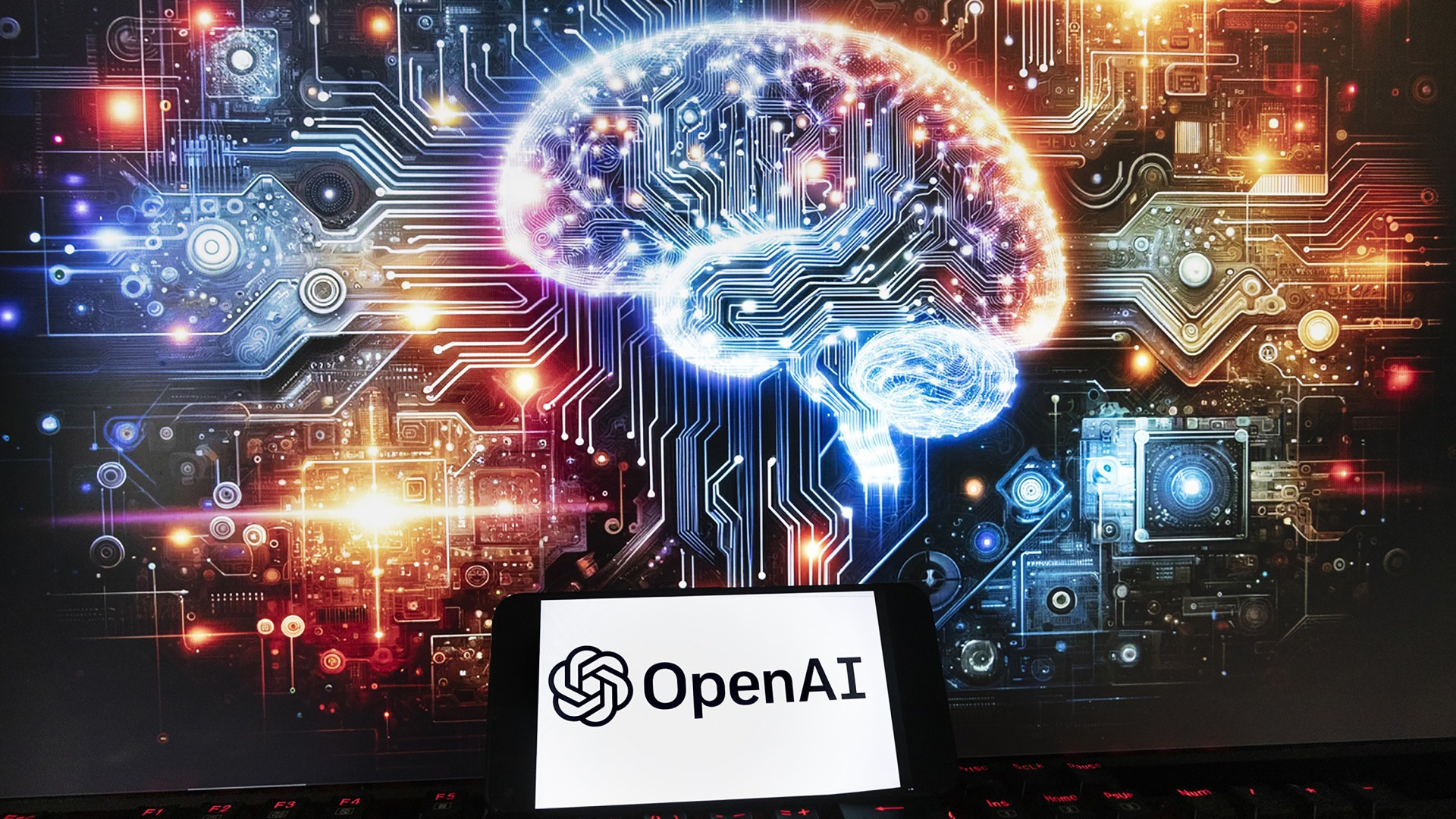
Sentite questa storia. Nel 1966 un giornalista milanese accetta la sfida della bizzarra teoria sulla possibilità di essere ibernati, ovvero congelati, in attesa di «rinvenire», vivi, di lì ad alcuni decenni. Lui si fa congelare, e addio presente. Viene risvegliato 40 anni dopo, e si ritrova stranito nei primi anni Duemila. Sempre a Milano, dove vede moltissime cose nuove, strabilianti. Le serate liriche alla Scala sono rimaste: però il nostro scopre che in alcune parti canore difficili degli «ingegneri della voce» sostituiscono i cantanti con gorgheggi artificiali. Il risultato non è male: «La stagione scaligera si è inaugurata con un Rigoletto interpretato, nelle parti di rilievo, da alcuni celebri “cantanti artificiali”. E devo ammettere che il Duca di Mantova, incarnato sulla scena dall’americano Fred Saratoga e vocalizzato dall’ingegner Tullio Cantele, mi ha letteralmente sbalordito».
C’è di più. Il giornalista redivivo scopre che in campo musicale si è addirittura cominciato a «comporre musica meccanica prodotta da calcolatori elettronici programmati a seguire un certo canone estetico». Con risultati dubbi, però: «Si era pensato che la macchina, per la rapidità fulminea nel ricercare tutte le combinazioni possibili, potesse dimostrare una fantasia straordinaria. In effetti si otteneva una gran varietà di motivi, ma senza una vera unità compositiva e soprattutto senza ombra di palpito umano». Ditemi voi se questa non è, pari pari, la profezia dell’intelligenza artificiale. Voi direte: ecco un giochino astuto di un autore che, fingendo di essere nel 1966 ma ben vivo oggi, profetizza quello che già sa. E no, invece. A scrivere quel racconto così profetico («Cronache del Duemila») fu, proprio nel 1966, il grande Dino Buzzati. Il quale non poteva certo immaginare che di lì a 50 anni l’umanità avrebbe trafficato attorno a una intelligenza artificiale. Poteva solo inventarlo, con quello strano fiuto del futuro che talvolta hanno gli scrittori acuti.
Sempre in quel racconto Buzzati scopre che durante spettacoli ed eventi spesso si percepisce «un diffuso brusio, come un cicaleccio sottovoce diffuso in tutta la sala». Incuriosito, scopre che «si tratta di un malcostume diffuso a Milano da pochi mesi, in seguito all’invasione di certi telefoni-televisori tascabili, coi quali è possibile parlare e vedersi entro un raggio di circa trenta chilometri. Una moda diventata una sorta di frenesia. Le donne passano intere giornate a chiacchierare e a spettegolare con le amiche fornite anch’esse di “teletini”. È un inconveniente noiosissimo, che ha provocato già molte proteste. Comunque, qualche provvedimento dovrà pur essere preso». Nel 1966 c’erano i telefoni fissi e la tv era arrivata da appena un decennio: nessuno avrebbe potuto allora prevedere l’invenzione degli smartphone. La premonizione di Buzzati ha dell’incredibile, anche se lo scrittore non osa immaginare videochiamate planetarie e si limita a un «ragionevole» raggio di trenta chilometri… Ma quello che soprattutto colpisce e fa pensare a una genialità intuitiva di ordine morale è che Buzzati non si limita nel 1966 a inventare intelligenza artificiale e smartphone con mezzo secolo di anticipo. Lui ha aggiunto, accanto alla meraviglia per il progresso tecnologico immaginato, anche l’intuizione dei rischi impliciti. E così per l’intelligenza artificiale dice che manca l’essenziale, ovvero il «palpito umano». E per l’invasione del chiacchiericcio generalizzato da smartphone, ne intuisce gli eccessi fino a dire che «qualche provvedimento dovrà pur essere preso». Aveva previsto tutto, presagendo anche gli inevitabili dibattiti sulla meraviglia del progresso tecnologico e sugli inquietanti effetti degli abusi. Ci siamo dentro in pieno. «Scongelata», la prosa vivida di Buzzati ci è contemporanea.

