La Storia è maestra di vita?
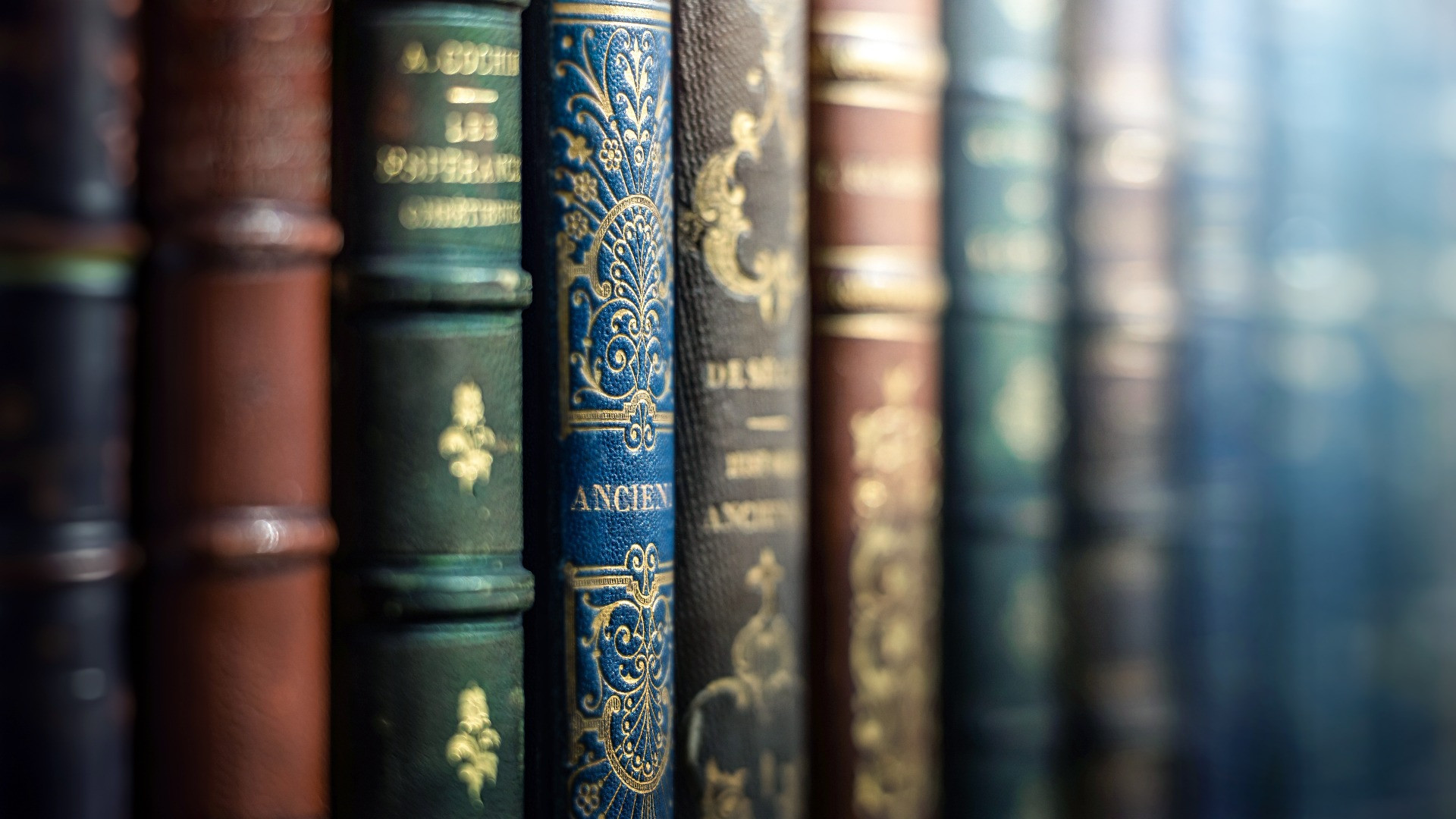
Mettendo ordine nei miei libri, ho ritrovato la tesi di laurea di mio nonno materno dal titolo «Agricoltura e politica doganale in Italia». Il lavoro accademico fu presentato alla Scuola Superiore di Agraria della R. Università di Bologna nel maggio del 1915, alla vigilia dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale.
Mio nonno, Prof. Alfonso Draghetti (la cui biografia è consultabile su: Treccani, «Dizionario Biografico degli italiani» Vol.41-1992), concludeva la sua tesi con la seguente frase: «…il nostro più sacrosanto ed indeclinabile dovere è quello di dare, ad ogni costo, il massimo sviluppo all’economia nazionale, la sola che può soccorrere il paese nei giorni più tristi e perigliosi e non affidarci troppo all’alea del commercio internazionale che, nella guerra europea moderna, si è mostrato la parte più fragile e vulnerabile dell’edificio economico delle nazioni.»
Rileggendo quelle parole, scritte centodieci anni fa, alla luce di quanto sta accadendo nel nostro tempo, mi sono reso conto che la descrizione della Storia, fatta da Cicerone nel De Oratore (II,9,36), come «testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, messaggera dell’antichità», contenga una verità pericolosa. Infatti la «Storia», pur essendo coronata da tutte quelle virtù, indossa di volta in volta abiti mimetici che permettono a medesimi eventi di riattualizzarsi nel tempo. È un dato di fatto che il nostro Continente, nonostante l’esperienza e le drammatiche conseguenze legate alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, pare essersi impegnato in un terzo folle tentativo il cui esito finale lo porterà, questa volta, al suicidio. Due motivi confortano la triste considerazione: le sofisticate armi moderne a disposizione e una consolidata programmazione. Tralasciando il discorso sulle prime essendo palese, è utile concentrarsi invece sulla seconda, che oggi appare sempre più chiara. Come noto, a partire dalla metà degli anni 80 del secolo scorso, si decise di dar progressivo corso a una nuova impostazione dei rapporti commerciali tra i Paesi, attraverso l’abbattimento dei vincoli posti a tutela degli interessi nazionali. Nel principio tutto ciò creò un’interdipendenza virtuosa tra nazioni detentrici dei necessari know-how e altre che funsero da «paesi-operaio», grazie al basso costo della manodopera. Tuttavia nel momento in cui questi paesi, spesso detentori delle materie prime, acquisirono e svilupparono i relativi know-how quel processo s’invertì, rendendo dipendenti le nazioni che si erano spogliate delle loro capacità produttive. A toglierci il sonno si è ora aggiunta la «guerra dei dazi» ed è su questo punto che si è verificato uno strano atteggiamento: essa fa più paura delle guerre vere. Un pessimo segnale, perché significa che ci stiamo assuefacendo ai propositi bellicistici che si levano da gran parte delle Cancellerie continentali. I popoli europei sono così indotti psicologicamente a ritenere, ancora una volta dal tempo di Eraclito, che «Polemos panton pater esti», ossia che lo scontro armato sia il padre di tutte le cose. Forse non ci è ancora chiaro che cosa ci stia preparando il prossimo futuro, ma possiamo almeno immaginare che cosa accadrebbe in caso di vera guerra se già oggi, anche in un avanzatissimo Paese come il nostro, accade che un medicinale, un bene di consumo, un servizio non sia più disponibile a causa di eventi lontani. Con questo non significa rimpiangere l’anacronistico istituto dell’autarchia; ma piuttosto domandarsi perché non si sia agito considerando, pur nell’era della globalizzazione, il classico principio del «buon padre di famiglia».
In tal modo si sarebbe assicurata alla popolazione almeno la possibilità di poter contare, in caso di bisogno, su un minimo dei servizi di base. È invece sconfortante osservare che nei supermercati anche uno spazzolino da denti ci arrivi dalla Cina e, nel contempo, sopportare che le Autorità ci parlino di sacrifici per ridurre le emissioni nocive! Credo che mio nonno, scrivendo quella frase nella sua tesi di laurea, sapesse che la storia è sì maestra, ma solo per gli studenti avveduti.

